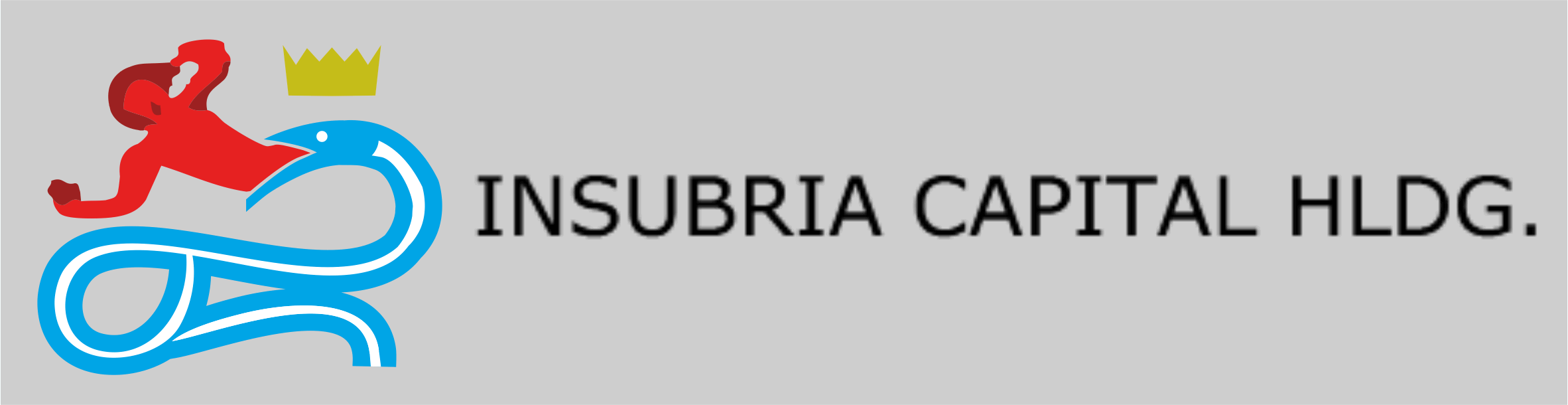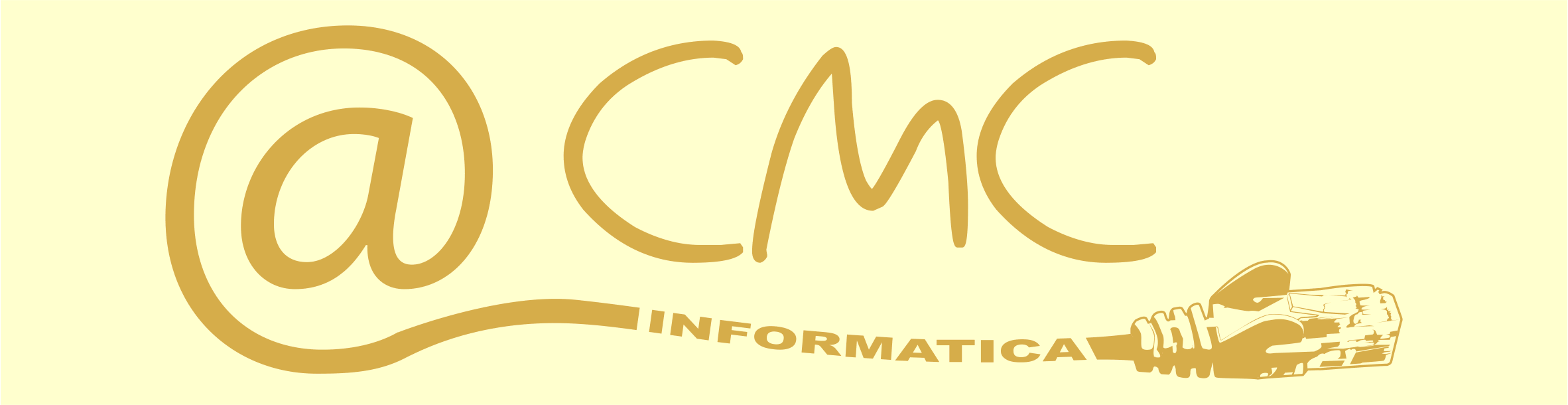Amen per il “risveglio” di Lidia
Scritto da Gianni SpartàSe si arriva a chiedere di riportare su un marmo dell’istituto di Medicina legale ciò che resta di Lidia Macchi a ventinove anni dalla sua atroce fine, qualcosa dev’essere accaduto da quando, imprevedibilmente e improvvisamente, è finito in carcere per omicidio un amico della ragazza, di sua sorella Stefania, del gruppo di Comunione e Liberazione: Stefano Binda. Sorprendente e nemmeno da pensare sarebbe il contrario. E cioè che unico indizio di colpevolezza fosse ancora, dopo un mese e mezzo, la perizia grafologica sulla lettera spedita a casa Macchi il giorno dei funerali della figlia e attribuita oggi alla mente delirante dell’assassino. Uno che in quella “notte di gelo e stelle” ha straziato il corpo di Lidia dopo averci fatto l’amore. Un amore malato di odio, pervaso di credenze fondamentaliste, ossessionato da manie distruttive: “Velo di tempio strappato”. Un amore descritto con frasi bibliche nella lettera intitolata “In morte di un’amica”.
Binda, “intellettuale dannato”, ha assistito alla scena e l’ha subito raccontata usando parole del Vecchio Testamento oppure l’ha vissuta in prima persona facendo poi il colto cronista di se stesso? Eccolo il dubbio da sciogliere. Anzi il dubbio che si è rafforzato nelle lunghe ore degli interrogatori di personaggi-chiave come Giuseppe Sotgiu, oggi “don”, amico del cuore di Stefano negli anni ‘80. Sul suo capo pende il sospetto di reticenza.
Non finisce di stupire e di addolorare questa inchiesta infinita. C’è ancora di mezzo un sacerdote “presunto innocente” come quello prosciolto con le scuse nel luglio del 2014. E’ c’è sempre in agguato una prova del nove genetica per chiudere un caso rimasto aperto troppo tempo, sottovalutato anche da magistrature superiori per 26 anni, ora resuscitato e sul filo dell’ultimo, disperato tentativo di risolverlo. Se è necessario osservare di nuovo i resti di Lidia, significa che nelle sue ossa, nell’estremità delle sue mani la scienza pensa si possa trovare qualcosa da offrire come termine di paragone all’accusa. Significa che questo termine di paragone lo si deve fabbricare daccapo dopo la distruzione dei vetrini sui quali gli investigatori dell’epoca avevano depositato gocce di sangue e di liquido seminale ricavati dal “corpo offeso”: impronte biologiche dell’assassino da sottoporre all’esame di un Dna poliziotto. E significa, infine, che avendo di nuovo a disposizione un profilo genetico si può avere la fortuna (ci vuole anche quella) di capire se tra i sei coltelli disseppelliti con i metaldetector nel parco Mantegazza di Masnago ce ne sia uno maneggiato dall’assassino.
Un alto magistrato come Carmen Manfredda, intenta a percorrere l’ultimo miglio di carriera, non si gioca il prestigio professionale e non sfida il comune senso dell’umana pietas, se non è convinta che riesumare il cadavere di Lidia può illuminare il buio. Ma dobbiamo riconoscere alla squadra mobile di Varese un lavoro di notevole efficienza investigativa, una sorta di riscatto rispetto all’inperdonabile leggerezza dei vetrini buttati via in tribunale. Questo caso ha tanti lati oscuri, inutile nasconderlo: una lettera arcinota dal Brennero a Lampedusa che solo 29 anni dopo illumina l’intuizione di un’amica di Binda e di Lidia; un assassino (presunto) che si libera dell’arma del delitto mentre sta andando a casa dei Macchi in compagnia della teste che lo ha incastrato; la difesa dell’imputato e il patrono della parte offesa riconducibili allo stesso movimento, quello di Comunione e Liberazione. Nulla di male, intendiamoci, solo qualche motivo di sorpresa.
Oggi ci piace pensare affettuosamente a mamma Paola, non solo per via della richiesta di “risvegliare” i resti di Lidia custoditi in una tomba a Casbeno, ma anche perché Lidia ieri avrebbe compiuto cinquant’anni se un coltello impugnato da un amico non l’avesse massacrata. “Mi auguro sia l’ultima ratio”, aveva detto in lacrime una donna forte e coraggiosa quando s’ipotizzò, anzi fu richiesta, la riesumazione. Lo è, dolce signora Paola, così sembra. Lidia era solita chiudere le sue lettere a don Baroncini, sua guida spirituale, con la parola “Amen”. E’ il caso di fare la stessa cosa pensando all’epilogo di un processo stracelebrato sui media mai in una pubblica udienza davanti a una corte.
*pubblicato originariamente su: https://giannispartareport.wordpress.com/
Nella foto: Carmen Manfredda

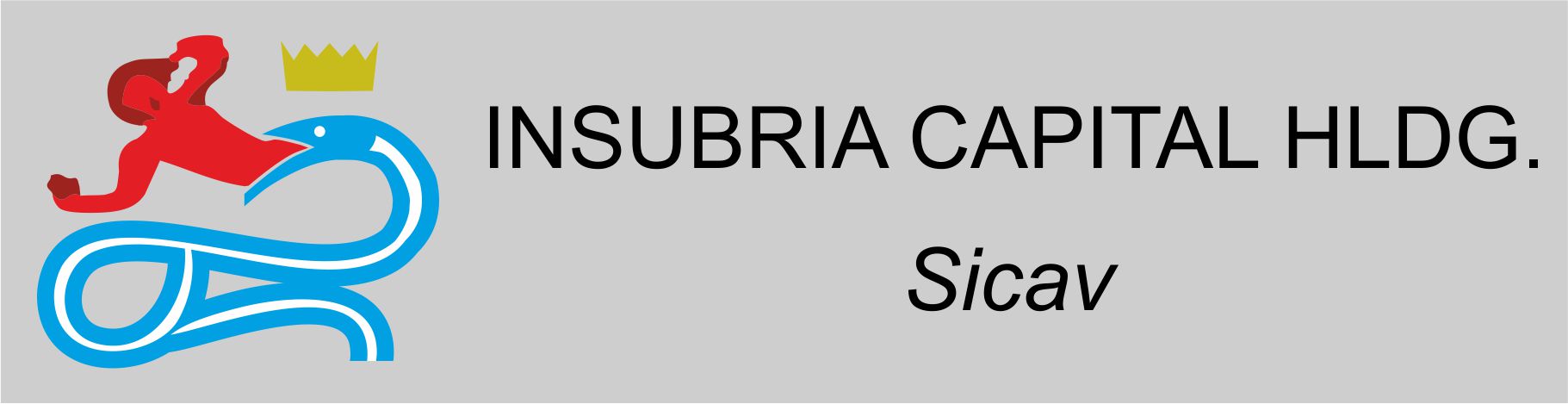




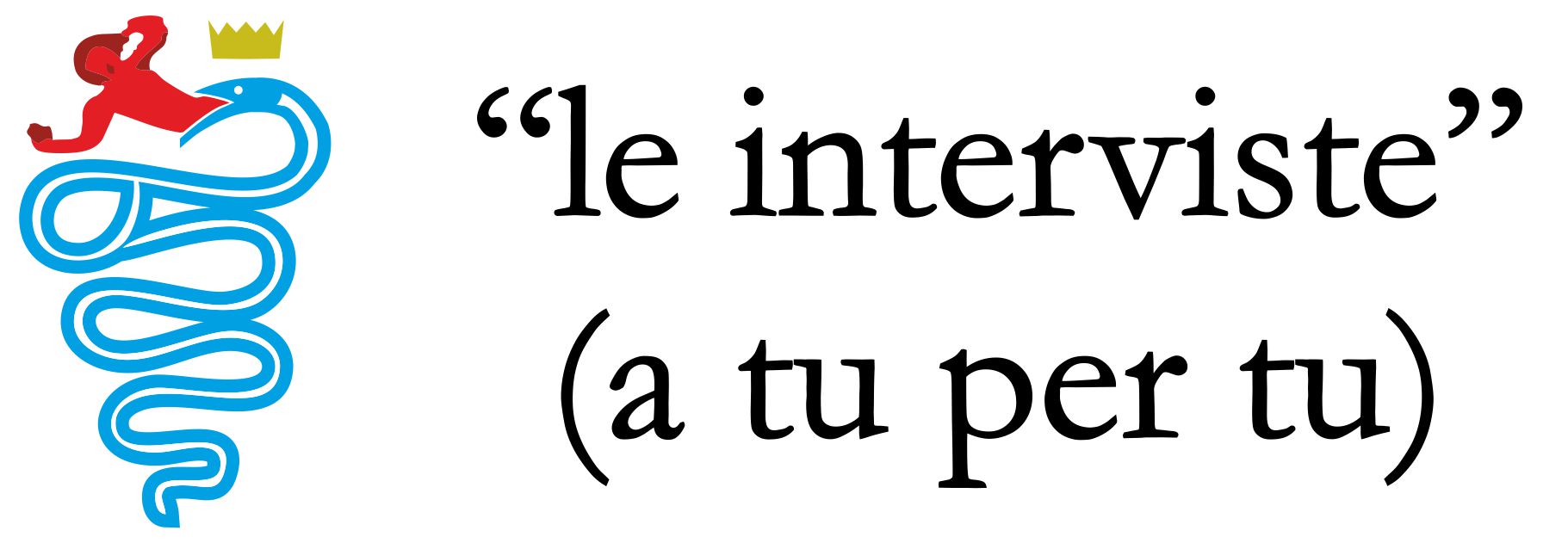








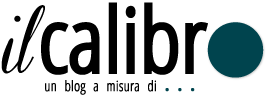

 O-Sense
O-Sense